Il temine parafrasi (latino paraphrasis, dal greco παράφρασις, riformulazione) su Wikipedia viene associato all’atto di traduzione di un testo scritto nella propria lingua ma in un registro linguistico distante (sia esso arcaico, elevato o poetico).
Emerge il carattere umile dell’intervento di parafrasi, perché esso è motivato soprattutto dalla necessità di affiancare, ad esempio, “a un testo di partenza giudicato difficile una versione in prosa corrente che ne appiani le difficoltà lessicali, semantiche e contenutistiche”, rendendo quindi più facile e comprensibile un contenuto complesso.
Abbiamo già dedicato spazio all‘artista inglese Graham Sutherland, ma la raccolta di scritti contenuti nel libro “Parafrasi della natura” consente di apprezzare meglio la sua pittura e, aggiungo, anche la pittura in generale.
Le descrizioni della baia di St. Bride, della pianura e delle punte che l’anticipano e la contengono, le escrescenze rocciose e le terrazze di Capo St. David, i paesi di case e fattorie bianco, rosa pastello, grigio azzurro e, poi, la zona a sud di questa parte del Galles, sono riflessi dell’entusiasmo e delle emozioni del pittore.
Questa è la regione dove Sutherland, a suo dire, ha imparato a dipingere. Un dipingere che non è il frutto di un’estrazione diretta dalla natura, perché non vi sono “soggetti pronti”, immediatamente trasferibili sulla tela, piuttosto materiali da archiviare nella mente, contenuti intellettuali ed emozionali da sedimentare e stagionare.
“Dapprima provai a dipingere direttamente sul posto, ma ben presto vi rinunciai. Presi allora l’abitudine di fare lunghe passeggiate immergendomi nella natura.”
Il processo creativo di Sutherland inizia con una passeggiata nella natura raccogliendo immagini, colori, forme, contrasti, dispersioni, “delle mille cose che vedo una sola giustapposizione di forme viene colta dai miei occhi come significativa”. Questo lampo, un’intuizione, porta alla parafrasi della natura, e non si manifestano conflitti tra immaginazione e realtà, solo l’umile volontà di tradurre in modo semplice l’essenza delle emozioni e delle immagini.
“Lo stadio preliminare, il contatto diretto, conduce poi a un processo diverso, controllato e ordinato dalla mente. La difficoltà sta nel conservare le emozioni del primo incontro, nel comprendere che la freschezza dell’istinto è vitale, nel saper distinguere quando una cosa, vista in un momento, potrebbe diventare, attraverso un lavoro di riflessione e approfondimento emozionale – studiando e ristudiando – un’opera d’arte.”
La pittura in questo caso è una traduzione del sedimento, ammettendo che una traduzione immediata, istantanea, sul posto possa, concedendo troppo alla necessità e alla superficie, portare l’autore a una scelta affrettata destinata, inevitabilmente, a una perdita di valore.
“Quando torna nel suo studio, il pittore ricorda: i suoi incontri sono ridefiniti, parafrasati e mutuati in qualcosa di nuovo e differente rispetto all’originale, e tuttavia identico”.
In realtà, in questo procedimento di assimilazione e proposizione artistica, si avverte un grande rispetto per la natura. La natura è, di per sé, un oggetto complicato, biologicamente complesso, e la sua lettura non può limitarsi alla pura esteriorità, alla descrizione, ma deve sprofondare nella ricerca dei fattori che determinano i processi di identità, le analogie, le corrispondenze e i contrasti.
Interessante a questo riguardo il racconto di Sutherland sulla genesi di una crocifissione commissionatagli dal vicario di St. Matthew, nel Northampton.
“In autunno cominciai a pensare alla forma da dare a quest’opera; nella primavera seguente avevo ancora in mente il soggetto, ma senza aver fatto alcuno schizzo. Mi recai in campagna: per la prima volta cominciai a notare i cespugli spinosi e la struttura della punte che laceravano l’aria.”
Le punte che lacerano l’aria sono dapprima un’immagine registrata nella mente, poi lentamente entrano a far parte di un percorso emotivo che cerca di afferrare il senso di un potenziale equilibrio tra tragedia e salvezza, mestizia e felicità. Anche il contrasto, scansione, tra l’azzurro e il nero diventa un elemento emotivo della crocifissione.
“Le spine sono nate dall’idea di una crudeltà potenziale, anzi, per me esse erano la crudeltà. Ho quindi cercato di rendere l’idea di una duplice torsione – se così si può chiamare – situando le spine in una cornice confortevole: cieli azzurri, erba verde, croci avvolte dal tepore.”
L’annullamento dell’imperfezione nell’azzurro del cielo richiama l’orrore della conformazione obbligatoria, in realtà è solo una parte del processo di trasformazione visiva di emozioni e contenuti, costantemente alla ricerca di un elemento essenziale che risponda alla ricorrente domanda sul significato recondito della rappresentazione.
Forse, un elemento è la meraviglia, l’emozione che prende, immobilizza e porta l’artista a esprimere e condividere.
“Quando dico di sentirmi immobilizzato, mi riferisco al concetto espresso dal Petrarca: Chiusa fiamma è più ardente; e se pur cresce, in alcun modo più non può celarsi.”




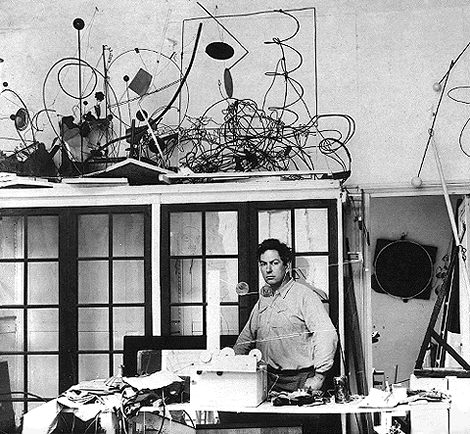























![Man.Ray.-.L'Etoile.de.Mer.(1928).DVDrip[(019094)18-24-13]](https://themadjack.files.wordpress.com/2012/05/man-ray-letoile-de-mer-1928-dvdrip01909418-24-13.jpg?w=600)



