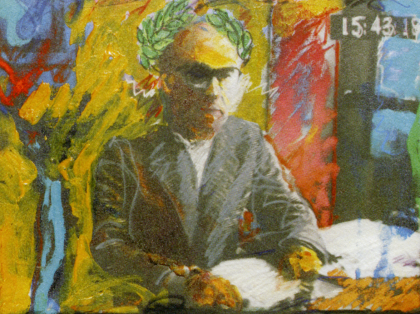“Dunque, cos’è il canto?
Solo una specie di sguardo (…).”
Così inizia la penultima breve poesia della raccolta “Arie” di Philippe Jaccottet.
Il riferimento è alla musicalità del canto, quindi anche alla sonorità della parola e poi un accenno agli effetti che lo sguardo ha su di noi, uno sguardo indagante e incantato, pronto a catturare associando, e legando tra loro, fenomeni colti all’esterno.
Nella bella prefazione al libro il poeta svizzero Fabio Pusterla cita Wallace Stevens, poeta anch’egli, rammentando queste sue parole: “E’ possibile che il mondo sia perduto per il poeta ma certamente non lo è per l’immaginazione. Parlo del poeta perché penso a lui come a un ambasciatore dell’immaginazione, e dico che egli ha perduto il mondo soprattutto perché i grandi poemi del paradiso e dell’inferno sono già stati scritti, ma rimane da scrivere il grande poema della terra.”
Per farlo, bisogna tornare indietro, ai colori selvaggi delle antefisse etrusche, alla musica popolare, alla religiosità implicita nelle danze dei Mamuthones e degli Issohadores sardi, all’allusione dionisiaca dei loro cortei e alla ricerca di un rapporto stretto, ancestrale, con la terra, con i suoi frutti e i suoi pericoli.
Non si tratta, infatti, di rappresentare, imitando, le manifestazioni naturali piuttosto di immaginarle e quindi di interpretare l’immaginazione, come hanno fatto Miró, Picabia, Picasso e molti altri, andando a indagare e poi a riprodurre sulle loro tele i frutti della terra immaginata, il portato immateriale di uno scavo radicale nelle profondità della materia.
“La terra totalmente visibile
misurabile
gravida di tempo
sospesa a una piuma che sale
sempre più luminosa”
A Jaccottet manca la tela, la luminosità del colore viene semplicemente dalle parole, per questa ragione ha bisogno della musicalità del verso, musica istantanea racchiusa in una dimensione cartacea limitata nel tempo e nello spazio ma efficace come il canto di un uccello, breve, nitido, poco prima di spiccare il volo.
“Io sono l’Angelo necessario della terra, – scrive nella sua poesia “L’angelo necessario” Wallace Stevens e continua – chi vede me vede di nuovo la terra, libera dai ceppi della mente, dura, caparbia, e chi ascolta me ne ascolta il canto monotono levarsi in liquide lentezze e affiorare in sillabe d’acqua; come un significato che si cerchi per ripetizioni, approssimando(…)”
Le brevi poesie di Jaccottet, appena simili a Haiku giapponesi, raccontano il ripetuto stupore al cospetto della natura e della terra: le pietre, le visioni, la neve e gli animali in fuga, appena distinguibili, tracce fresche o macerate dal vento e dalla pioggia, l’acqua e il fuoco.
E’ lo stupore nello sguardo dell’uomo che coglie immagini e movimenti, segni di presenze o di passaggi, e subito è portato a pensare, a tradurre lo stupore in abitudine, in un modo tranquillo di ascoltare cogliendo però le differenze e anche le ambiguità visive e musicali.
“Si direbbe che un dio si risvegli,
osserva fontane e serre
La sua rugiada sopra il nostro parlare
sopra il nostro sudore”
E’ l’alba, ancora una volta e il grande poema della terra attende di essere completato, intanto, Jaccottet sogna di “scrivere un poema che sia cristallino e vivo come un’opera musicale, puro incantamento.”